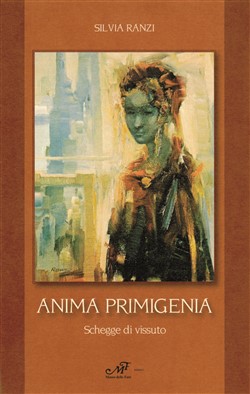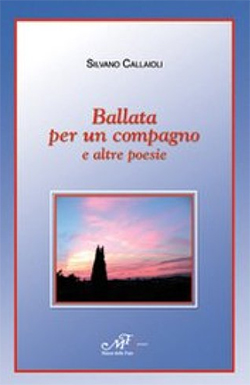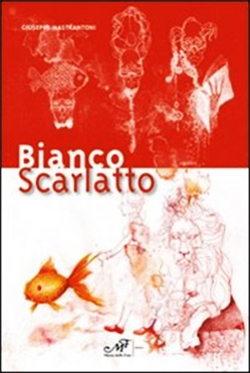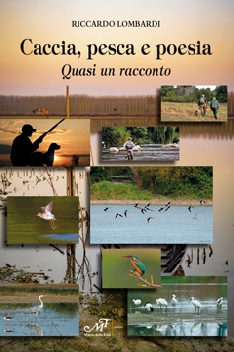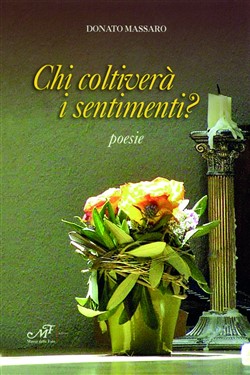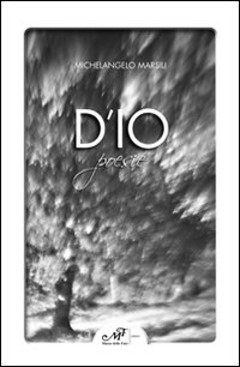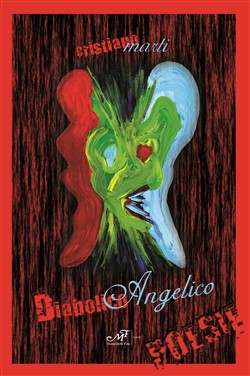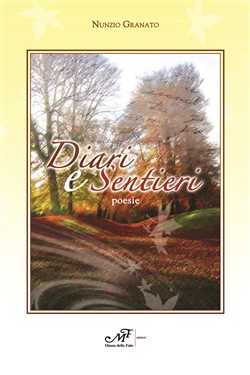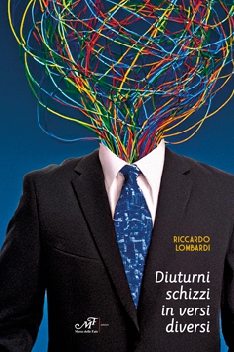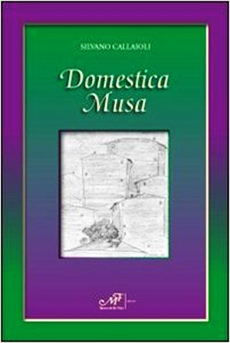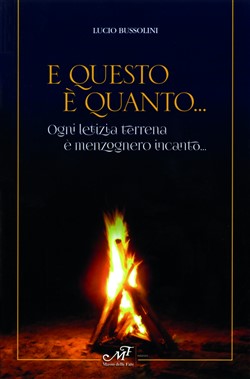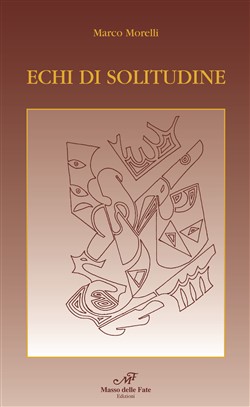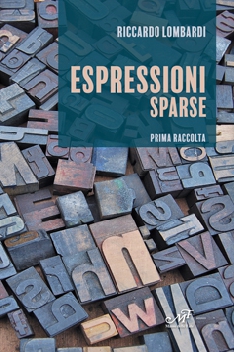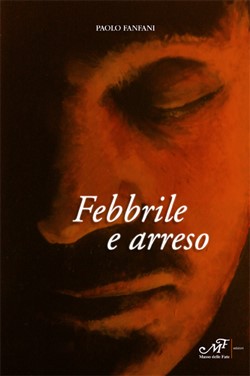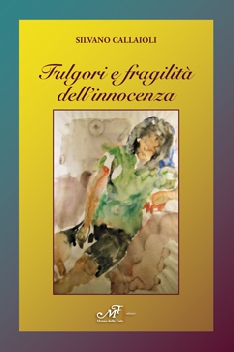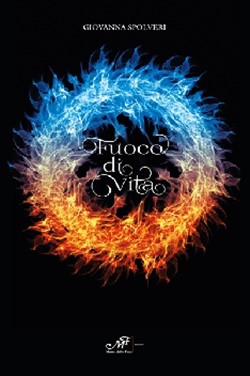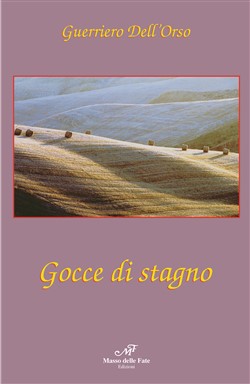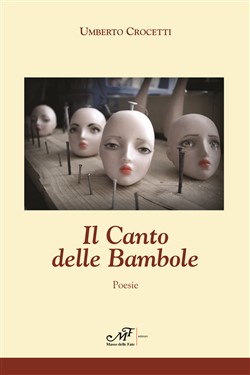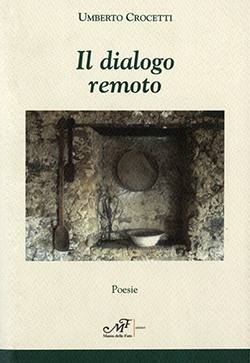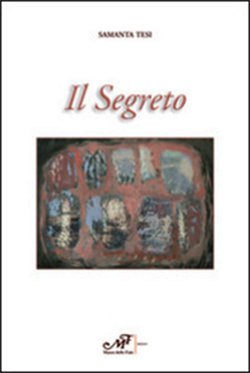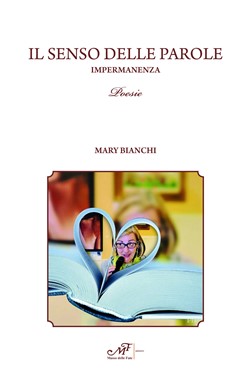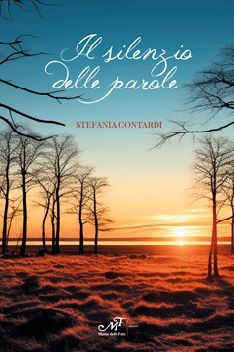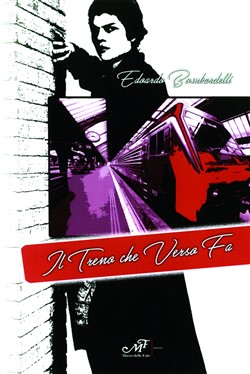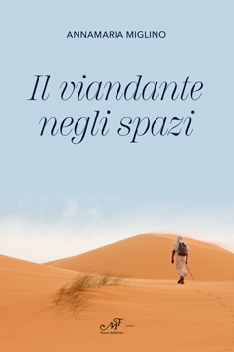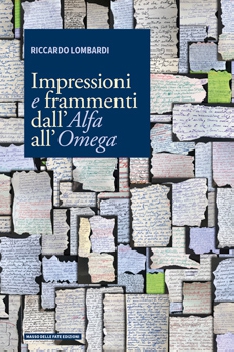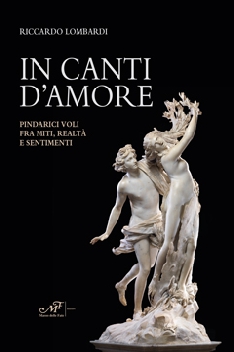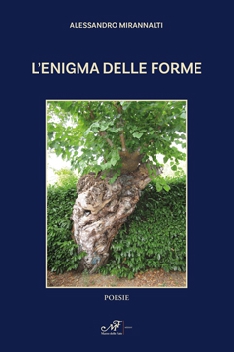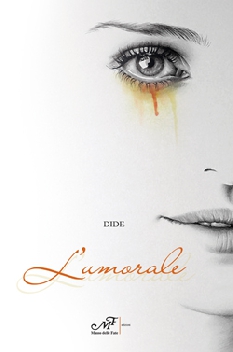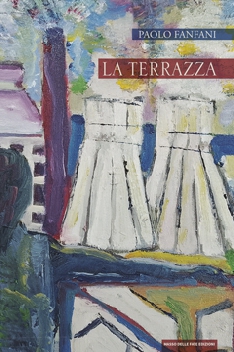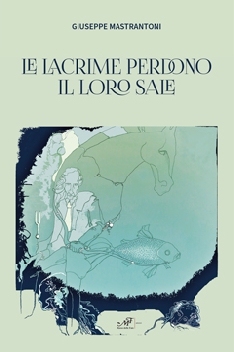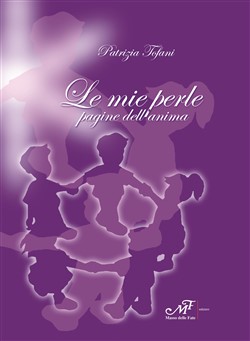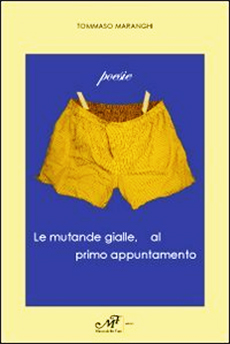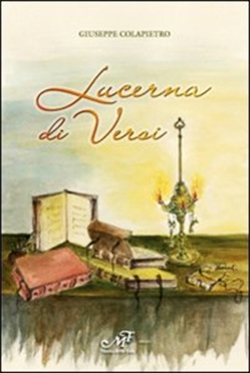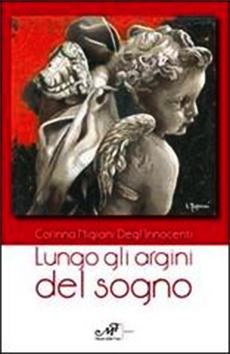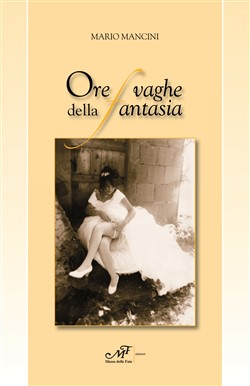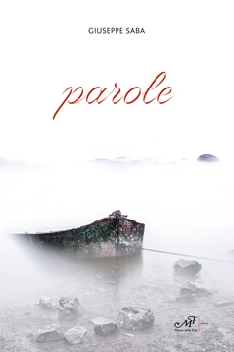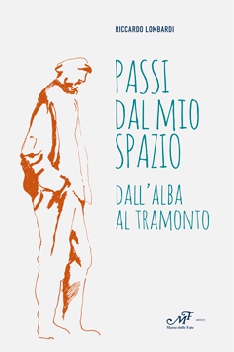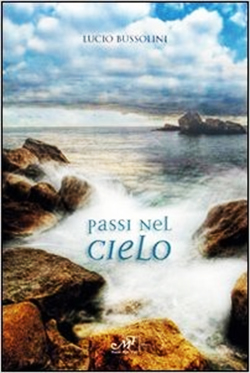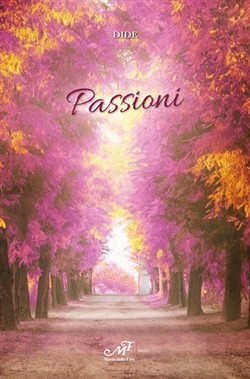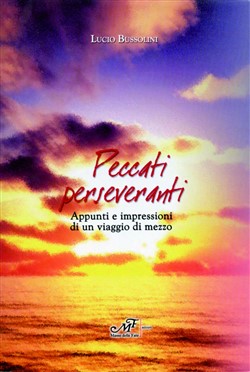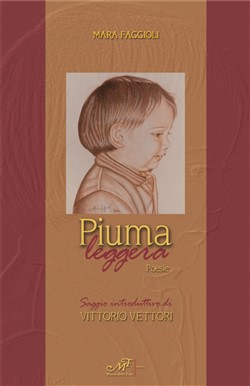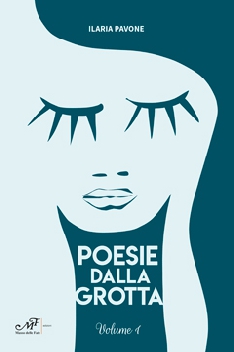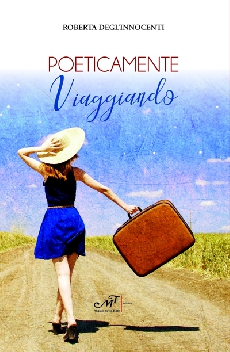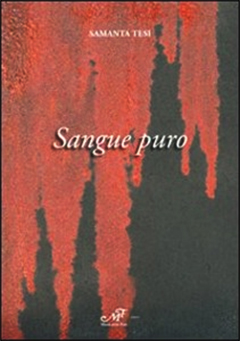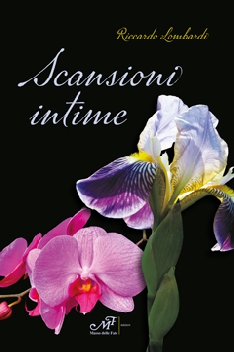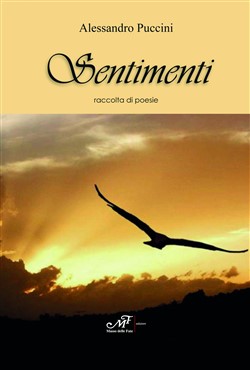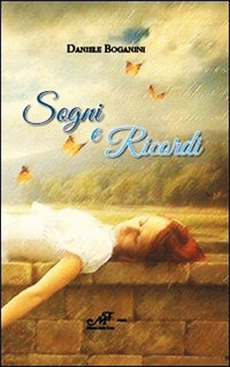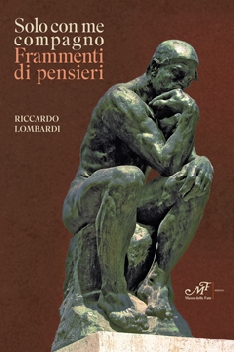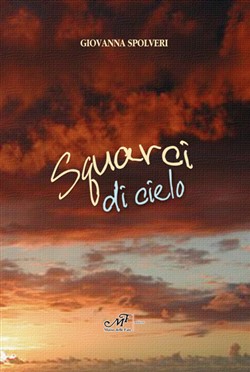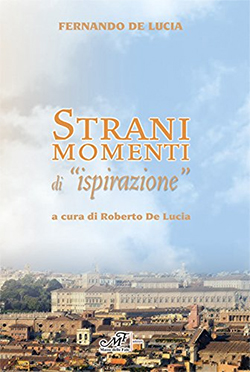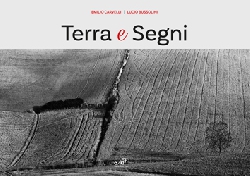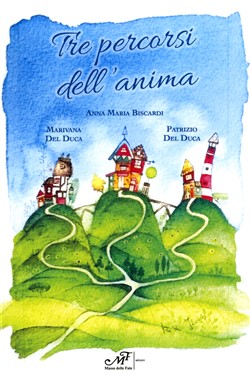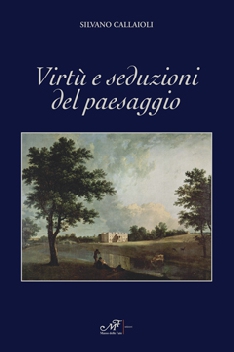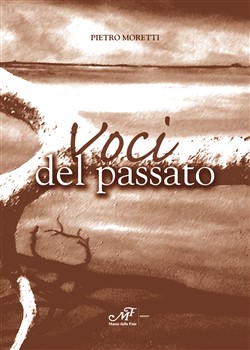Viottole Fiorentine
Viottole Fiorentine
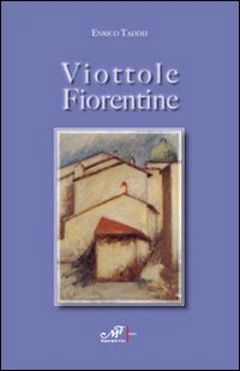
Autore : Enrico Taddei
Collana : Mielamaro
ISBN:978-88-6039-307-4. , Anno 2014
pagg. 54; cm 14X21 Italiano
Br.
€ 12.00
Descrizione
Non occorre leggere, o citare, o addirittura ricomporre le parti di un libro per mettere insieme le parole qui necessarie ad accompagnare queste «viottole» di Enrico Taddei.«Viottola» è un nome dal suono abbastanza rotondo, che non troppo si addice all'asperità e alle fatiche di questa lingua – tutto sommato nuova, o estranea ad una certa tradizione – che ora intende proporsi alla nostra lettura: una lingua del vicinato e dell'usato, però mediata dall'uso di una forma.
Una lingua, ancora, intraducibile e che perde parte della sua energia a contatto con l'italiano: perde in oscurità e perde in intensità, rivelandosi, forse, per questo, ancora più vera.
Siamo abituati a pensare al vernacolo come ad una serie di "biascicamenti", di strascicamenti, di bassa intenzione, eppure anche il vernacolo è in grado di rivelarsi come una lingua dura e molle: molle e dura a seconda delle situazioni e a seconda del suo porsi o proporsi come intenzione o semplicemente come capacità d'espressione, come via di fuga.
Quella di Taddei, proprio a partire da qui, sembra una fuga centripeta, costretta quasi quotidianamente a contemplare il suo centro, fino a sfociare nell'idioletto, nella dimensione del privato.
Le Viottole fiorentine prendono solo a pretesto la lingua d'altri per costruire, più o meno artificiosamente, un pastiche che non è sperimentale ma sperimentalmente emotivo: e dentro l'esperimento siamo in grado di riconoscere una molteplicità di echi, da Cavalcanti a Pascoli, a quella tradizione lirica che conosce bene i modi e i tempi dell'invettiva e dell'elegia.
Per questo motivo, più che per altri, si può marcare l'accenno di qualcosa, di una possibile estraneità, rispetto soprattutto all'uso che del dialetto è stato fatto nel corso del Novecento a noi più vicino, dovendo semmai ricorrere ad esempi che affondano le loro radici nell'Ottocento: possiamo pensare ad esempio a Delio Tessa, benché Tessa risulti ancora più acceso, più espressionista, anche nelle intenzioni.
La lingua delle «viottole» è una lingua accesa, è vero, ma i suoi caratteri non filtrano dall'esterno, sono stratificati nei luoghi dell'io, di questo centro-coacervo da cui il soggetto della poesia tenta di liberarsi, in maniera più o meno disperata, dividendo il dentro dal fuori in due sezioni ben distinte, e affidando le sue intenzioni ad una sorta di proemio, come ad una confessione dove le muse risultano – per amplificare un sintagma di Sylvia Plath – altamente inquietanti.
Cosa deriva da questa inquietudine non è certo possibile stabilire o sintetizzare in poche righe, meno che mai a priori, prima che un testo veda la sua luce e incontri il suo pubblico: rimane a discrezione dell'ascolto e della lettura, al di là delle frequenti sincopi che questo dettato ci pone, la facoltà di sapere o di poter capire dove finisce «la bella proiezione» di queste parole, indicata Pe' filo e pe' segno.
.